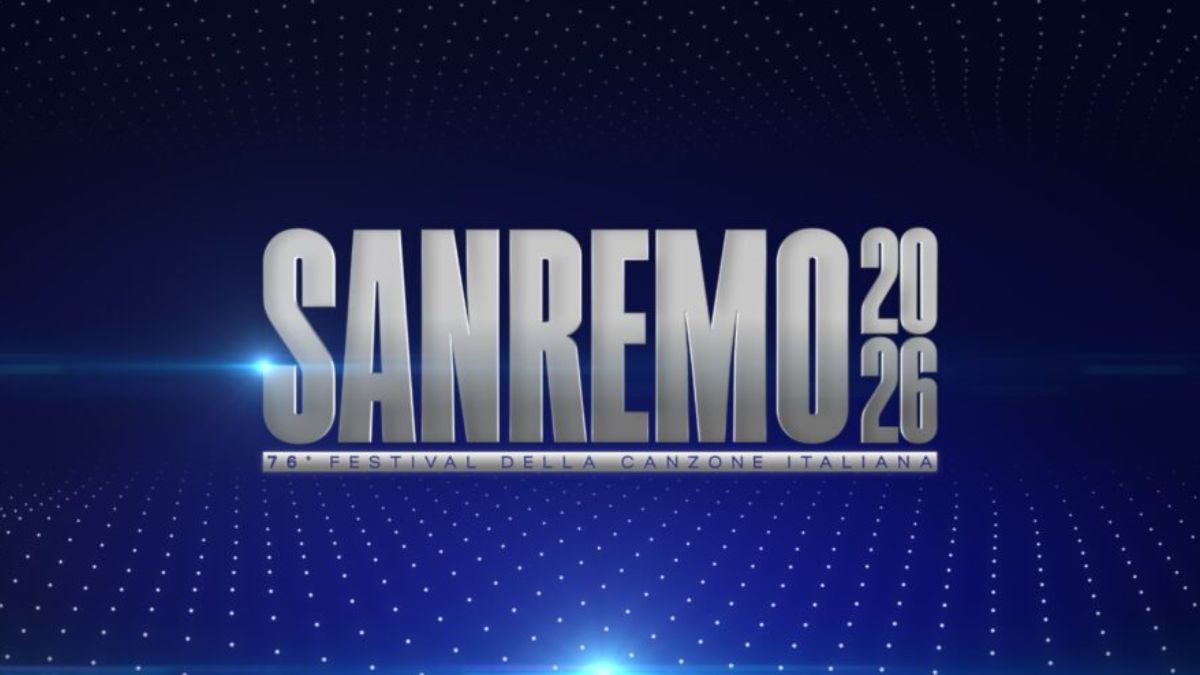Da poco è uscito il saggio ‘L’etica stanca. Dialoghi sull’etica pubblica’ di Rocco D’Ambrosio, edito da Studium, Roma, 2025, pagg. 208, euro 19,00. Il filosofo pugliese, presbitero della diocesi di Bari e presidente dell’associazione di promozione sociale “Cercasi un fine”, è ordinario di Filosofia Politica presso la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Giornalista pubblicista ha già scritto diversi saggi su temi politici.
Professor D’Ambrosio, può dirci come nasce l’idea e la successiva realizzazione di questo saggio a più voci sull’etica pubblica “L’etica stanca”, dove “stanca” può essere letto sia come aggettivo che come verbo?
Infatti, il titolo propone una piccola bivalenza. “Stanca” può essere l’aggettivo nel senso che l’etica si è stancata e così la trattiamo come una persona che si è stancata di indicare alle altre persone ciò che è giusto, ciò che è vero e ciò che è bello. Oppure può essere un verbo e in questo caso l’etica annoia, ammorba, crea fastidio e in questo caso la trattiamo come una persona che provoca le altre che non la ascoltano proprio perché è noiosa e pesante. L’idea del saggio era quella di avere un confronto con persone, sono 51, che lavorano nel pubblico a vario titolo: colleghe e colleghi del mondo accademico, della pubblica amministrazione, teologi e non solo. Persone, in maggior parte amici o conoscenti, con le quali in questi anni ho sempre tenuto vivo questo confronto che mi è sembrato utile metterlo su carta. Così li ho citati facendoli entrare nel discorso che io porto avanti.
Nel saggio si legge che da tempo lo Stato è “una mucca da mungere” con l’etica pubblica piegata alla sfrenata mentalità capitalistica del profitto a ogni costo. Quanto sta peggiorando la situazione con l’arrivo delle Big Data, quelle che nel suo saggio sono indicate come “mucche private al servizio del pubblico”?
Sta peggiorando parecchio, non solo secondo me ma secondo molti, perché siamo in un momento in cui si sta privatizzando il pubblico. Se prima i tanti servizi, i dati, ma anche le aziende, potevano essere pubbliche così che a mungere erano privati, ora che lo Stato è in crisi di risorse e con debiti di bilancio, si appaltano all’esterno questi servizi, questi dati, queste aziende. Si privatizzano dei settori, particolarmente quello tecnologico compresa l’Intelligenza Artificiale, proprio il campo dei Big Data. Non è più, quindi, uno Stato sfruttato dal privato ma è un privato che ha privatizzato il pubblico. Per fare un esempio semplice: io privato creo le cosiddette intelligenze artificiali, oppure gestisco i satelliti per la sicurezza nazionale o, ancora, gestisco la raccolta dei dati sensibili.
Nel saggio si sostiene che le “relazioni”, quando in presenza fisica, intellettuale ed emotiva, concretizzano la nostra etica comportamentale. Cosa accade quando la relazione è mediata dalle piattaforme, come avviene spesso oggi?
È una relazione monca. Se noi facciamo una video chiamata che cosa c’è di fisico? C’è solo la visione ma non la concretezza del corpo di un altro, ascoltiamo solo la voce e quindi le emozioni sono limitate a quella. Dunque, una relazione monca perché manca di emozioni, di realtà corporea.
Si parla di giustizia come virtù etica cardine per un’istituzione e di quanto oggi questa virtù sia in crisi. È solo colpa della mancata educazione alla giustizia o c’è qualcosa di più?
L’educazione è un fattore di base fondamentale che riguarda tutti: politici, semplici cittadini, responsabili di istituzioni. Se manca un senso di giustizia è perché le persone non sono cresciute nella virtù della giustizia. Ma non finisce qui perché ci sono anche fenomeni che riguardano l’attualità quando si vede che chi detiene un potere, spesso, si sente al di sopra della regola di giustizia, o della legge o, comunque, del campo della legalità. Qui ho usato termini diversi ma il succo è lo stesso: si sente al di sopra e, quindi, piega la giustizia ai suoi interessi oppure la trascura completamente. L’esempio classico è quello della Costituzione, ignorata od offesa, che addirittura si tenta di piegarla con riforme ignobili. L’esempio, ancora in atto, il fatto che noi andiamo al voto senza poter scegliere i nostri parlamentari; continuiamo a votare un pacchetto già pronto nonostante che la Corte costituzionale abbia detto che ciò è anticostituzionale.
L’etica pubblica è cosa seria e impegnativa ma, come si legge nel saggio, può essere praticata anche attraverso l’umorismo. Qual è il limite dell’umorismo per essere propedeutico all’obiettivo dell’etica pubblica?
L’umorismo è vedere l’aspetto leggero di tutte quelle situazioni che sono pesanti come la vita nella sfera pubblica. Vedere l’aspetto leggero non significa banalizzarlo ma vuol dire fare un sorriso, prendere fiato, rinfrancarsi un po’. L’umorismo non è la buffoneria che serve a far ridere e non è neanche il riso. L’umorismo alleggerisce la vita istituzionale, politica, pubblica. Il problema è che l’umorismo deve essere praticato e ricevuto da persone intelligenti che hanno anche una condotta morale di alto livello, non dico ineccepibile perché sbagliamo tutti, ma sicuramente di livello. Questo è necessario perché facilmente l’umorismo può degenerare in buffoneria, in offesa, in ironia sagace e un po’ cattiva. Invece l’umorismo deve alleggerire il peso della vita pubblica.
Lei sostiene che le dinamiche pubbliche si sviluppano attraverso la politica, la pubblica amministrazione e anche il volontariato. Ce ne sintetizza le condizioni attuali?
Ho scelto queste tre dinamiche perché, a mio avviso, sono emblematiche. La politica: la crisi della politica è sotto gli occhi di tutti, finendo di essere scienza architettonica come diceva Aristotele è diventata scienza, o meglio, attività che ricerca il consenso finalizzato al potere e, spesso, quel potere è finalizzato agli interessi di istituzioni private o comunque di singoli. Pubblica amministrazione: la diretta esperienza al Ministero dell’Interno ma anche le conoscenze di altri comparti della Pubblica Amministrazione favorisce la mia convinzione che questo settore non merita tutte quelle critiche, un po’ qualunquiste, che le abbiamo riservato. Certo, ci sono anche qui persone incompetenti, persone che non hanno voglia di lavorare, ma sono convinto che se questo Paese, il nostro, l’Italia, non ha subito un collasso in anni molto difficili, e per alcuni aspetti anche nel presente, lo si deve a una classe di pubblici amministratori competente, dedita, che nel silenzio e nel nascondimento porta avanti questa grande macchina che è l’Italia. Volontariato: sono presidente di un’associazione di volontariato e vedo per la nostra realtà, ma anche per le altre, quanto il settore in Italia è in crisi. Se la qualità dei volontari è salita il numero è terribilmente sceso mentre i servizi da prestare sono tanti e quindi siamo in forte difficoltà.
Una domanda che va oltre il saggio. In altre sue interviste ha sempre sostenuto che il pontificato di Francesco sia stato molto importante sia dal punto di vista dottrinale che dal quello politico e sociale. Ha scritto che Francesco non ha vissuto da Papa Re ma da semplice cristiano che sapeva soffrire insieme agli altri. Cambierà qualcosa con Leone che intanto è già tornato a passare l’estate a Castelgandolfo?
Sono convinto che in termini di contenuti non cambierà niente perché tutti i Papi, a partire dal 1891 con Leone XIII, da cui lui prende il nome, fino ad oggi, non si sono mai smentiti tra di loro sulla linea sociale, politica, economica e culturale. Naturalmente lo stile di quest’uomo, come è giusto che sia, è diverso. Quindi ben venga, la Chiesa è bella perché è varia. Poi c’è il problema che Papa Francesco, alcune volte, ha trascurato il governo interno perché più impegnato ed esposto alla testimonianza esterna della Chiesa nella quale ha portato un grandissimo contributo. Per questo l’attuale Papa deve anche pensare all’interno e, nonostante l’eredità difficile sulle spalle, credo che ce la farà. In questi primi giorni mi dà l’idea di una persona che sta prendendo le misure nel gestire sia le crisi esterne come quelle delle terribili guerre in corso che quei problemi interni che dovrà assolutamente risolvere. Diamogli un po’ di tempo.