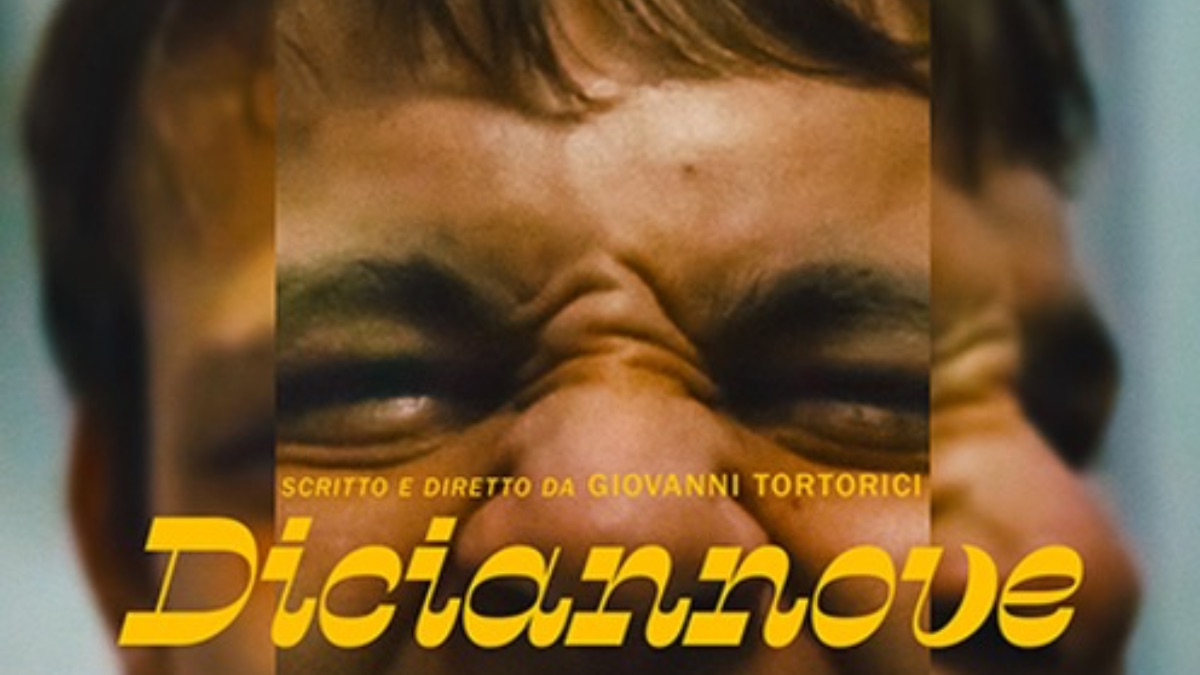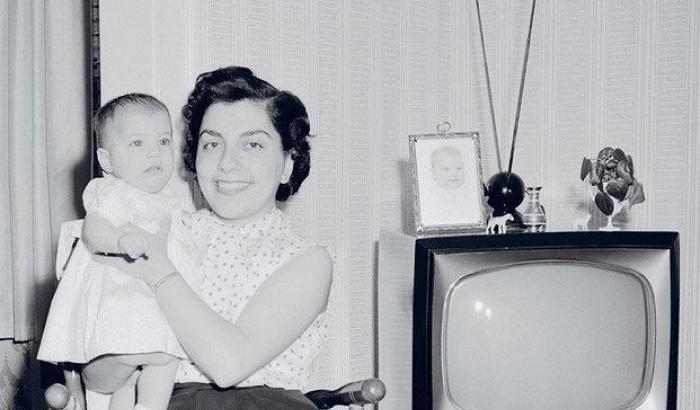di Caterina Abate
Il 27 febbraio è uscito nelle sale Diciannove, film opera prima di Giovanni Tortorici, con un buon riscontro di critica, già prima dell’uscita ufficiale (ha partecipato a diversi concorsi internazionali, tra cui Venezia nella sezione Orizzonti lo scorso settembre). Tra i produttori del film figura Luca Guadagnino (nelle sale dal 17 aprile con il film Queer, adattamento del romanzo beat di William S. Burroughs, n.d.r.), con cui Tortorici ha lavorato da assistente di regia a We Are Who we Are e curatore del backstage in Bons and All e che ha reso possibile questo debutto cinematografico, innamorandosi a ragion veduta della scrittura del giovane regista palermitano.
La storia è quella di Leonardo Gravina, il doppio cinematografico dello stesso Tortorici, interpretato da Manfredi Marini-anche lui con Diciannove alla sua prima volta sullo schermo-eppure impeccabile, quasi senza sbavature. Il film si apre con una scena di copioso sangue perso dal naso, un incipit piuttosto forte e realista, forse debitore di un certo cinema est asiatico (ma probabilmente anche di Bons and All di Guadagnino) e prosegue attraverso l’intenso ed intimo viaggio di scoperta del sé per tre città Londra, Siena e Torino, tre diverse fasi di consapevolezza dell’io. Solo l’arrivo di un mentore, lo psichiatra Sergio Benvenuto, riuscirà a re-incardinare Leonardo-detto Lele- alla realtà contemporanea, avviando un canale di dialogo che sarà capace di far cadere il velo di superbia post adolescenziale.
Più che un manifesto generazionale, come è stato da taluni percepito, il film può essere inteso come una storia di formazione in cui ognuno può rivedersi, senza aver necessariamente vissuto la storia di Lele nella sua identica forma. Tortorici trasfigura i suoi diciannove anni nel film e lo fa in un modo personale, profondo e a tratti ironico, comunque mai banale. Ciò che accade a Lele non è mai nulla di eccezionale: è un ragazzo che si arrocca sulle proprie passioni, cementificandole in ossessioni nell’arco narrativo dei suoi diciannove anni e scegliendo la solitudine per viverle appieno.
Dopo la sua brevissima permanenza a Londra vira su Siena, che promette di essere il luogo migliore in Italia dove studiare letteratura. Lele ha, però, una personalissima idea di come lo si debba fare: rifugge l’autorità del professore universitario ma non quella degli ottocenteschi commentatori di Dante; del professore rifiuta un 26 all’esame, tramando addirittura di denunciarne la totale incompetenza.
Talmente compenetrato nello studio delle “belle lettere” da circondarsi di libri antichi (sulle scene proprio quelli di proprietà di Tortorici stesso), Lele piange per i sonetti di San Francesco, piscia su di un testo antico con tesi che non lo convincono, brama l’identificazione con Leopardi e vive tutta la sua vita dentro una stanzetta, in cui dorme, cucina, studia, lasciando tutto il mondo fuori.
Anche la sua sessualità è disarticolata in questo anno, non prende mai veramente il via, viene solo accennata, perché non ha lo spazio per maturare. Le sue opinioni sono sempre nettissime, come quando dice che Pasolini non sa scrivere. Lele sembra vivere in un mondo sospeso nel suo antro, nella sua stanzetta di vicolo del Tiratoio (per chi ha familiarità con Siena), che è la stessa in cui Tortorici ha vissuto nel suo anno da studente dell’UniSi. Eppure, anche la vicenda senese avrà vita breve.
È interessante il modo in cui il regista connota le città in cui il protagonista si muove, ed è forse inconsciamente specchio di quello che queste rappresentano per lui: a Palermo lo sguardo di Tortorici si sofferma sui monti e alla fine sul mare, come a voler dire le radici; a Londra vediamo i sobborghi, la metro, le luci di Piccadilly, una città frenetica, forse gli studi di economia che Lele rifugge subito dall’intraprendere; di Siena vediamo gli scorci dei vicoli, piazza del Campo di notte, piazza Gramsci, l’università, gli interni del Santa Maria della Scala, una città di laterizi e storia tutta chiusa in sé stessa, come l’anno di studio matto e disperato che Lele si costringe a vivere.
Di Torino, infine, l’esterno di un cinema, come a volerci suggerire dove porterà questo ennesimo trasferimento. Un altro contrasto nettissimo, rispetto alla piccola stanzetta di Siena, mal arredata e mal tenuta, sono gli interni contemporanei nella casa a Torino dello psichiatra Benvenuto, dove possiamo presumere Lele si recherà periodicamente, idealmente a dirci che la bolla di nevrosi e superbia solitaria è scoppiata.
Anche le suggestioni sonore sono ben articolate nel film: dalla musica classica senza difficoltà accostabili alla vita che Lele sta scegliendo di vivere-che poi sono la sua personalissima scelta di momentanea ribellione; alla techno dei brevi passaggi in discoteca; alla trap che Lele incrocia a Siena a piazza Gramsci, quando incontra un gruppo di ragazzi più giovani di lui, il momento in cui si istilla l’interesse per un altro ragazzo, che resterà meramente platonico. E poi la più classica delle colonne sonore a Siena, i tamburi della contrada e l’impressione dell’acqua che scorre a Fontebranda, vaga illusione del mare.
Nel film sono presenti anche degli inserti di animazione di Margherita Giusti, vincitrice nel 2024 di un David di Donatello per il corto The Meatseller, a simulare un’esperienza di Lele con le droghe, ben coniugato con il resto del film. Stilisticamente Tortorici attinge alla nouvelle vogue e al cinema est asiatico anni ‘80 e ‘90, ma traghettandoli nel ventunesimo secolo forse inconsciamente attraverso la mumblecore, Guadagnino, Dolan e Euphoria. Nel complesso Diciannove è una buona prova sia per la qualità della scrittura, caratterizzata da dialoghi reali e non fittizi, che della regia, a maggior ragione per essere la prima prova per Tortorici, con una visione molto personale e fresca, che si spera possa mantenere anche nei suoi prossimi lavori.